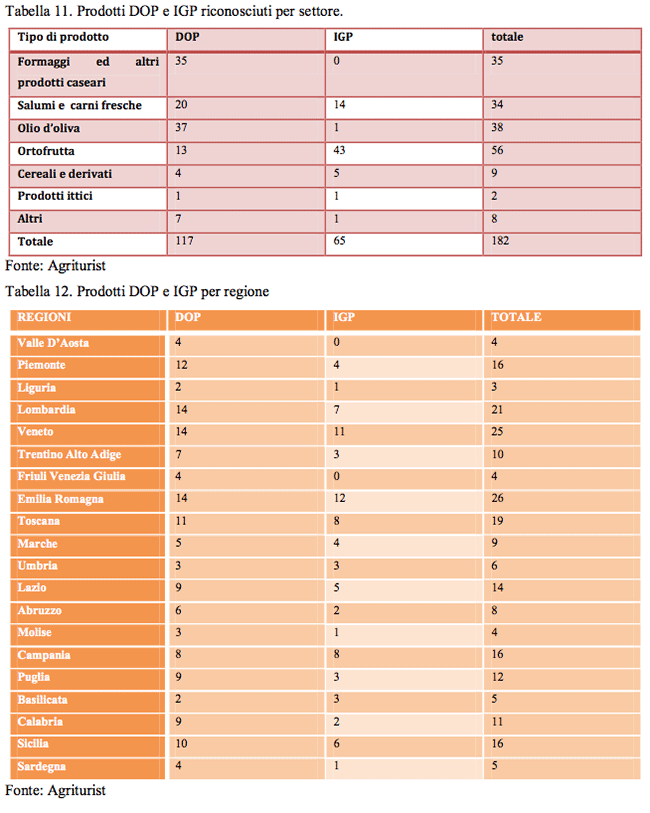L'agriturismo rappresenta un nuovo modo di fare turismo, oggi definito culturale, rivolto ad un pubblico di cultura medio elevata alla ricerca non solo di esperienze visive, gustative ma anche emotive.
Pur restando una tipologia di ospitalità con caratteri che possono definirsi “familiari”, l'accuratezza nella preparazione degli alloggi, nella gestione della ristorazione, nella proposta di attività ricreative, nella correttezza delle informazioni da fornire ai clienti, nella conoscenza del territorio rappresentano un “plus” non riscontrabile altrove. L'agriturismo si è ritagliato un ruolo peculiare nello sviluppo del cosiddetto turismo minore, grazie alla sua capacità di rendere appetibili aree meno organizzate e difficilmente raggiungibili favorendo la promozione del territorio.
Si può infatti affermare che l'agriturismo sia oggi il settore che "vende" più territorio rispetto al turismo tradizionale.
Questa peculiarità è resa più forte dal ruolo che la componente agricola svolge nei confronti dell'ambiente circostante e dalla capacità dell'impresa agricola di destinare le produzioni aziendali verso una gamma di alimenti e di servizi caratterizzata dal territorio di appartenenza.
Le prime misure comunitarie a favore dell'agriturismo e del turismo rurale risalgono alla metà degli anni '80 con i regolamenti CEE 797 e . 2088 del 1985.
In particolare, il primo concedeva, all'interno del regime di aiuti agli investimenti in aziende agricole per i piani di miglioramento, la possibilità di effettuare investimenti a carattere turistico o artigianale nelle zone svantaggiate; mentre il secondo, prevedeva la concessione di incentivi per l'adeguamento dei fabbricati rurali destinati allo svolgimento di attività turistiche e per interventi di promozione del turismo in aree rurali.
L'attuale sviluppo del settore agrituristico, è legato al ruolo dei Regolamenti Comunitari, emanati nel 1999, in approvazione della riforma dei Fondi Strutturali e quelli relativi alle politiche per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In particolare, il Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG (CE 1257/1999), diretto ad incentivare e sostenere processi di sviluppo rurale integrato e sostenibile, all'art. 33, prevede tre misure per la diversificazione aziendale ed economica, di cui
la Misura “p” relativa a “Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini” individua, tra l'altro, interventi a sostegno d'investimenti aziendali per attività e strutture agrituristiche.
Recentemente, nuova enfasi al ruolo multifunzionale dell'impresa agricola è stata data dalla nuova PAC, a cui il secondo pilastro (le politiche di sviluppo rurale) ha attribuito maggiore centralità con misure strutturali destinate al potenziamento del settore agricolo, agroalimentare e forestale; alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio rurale; al miglioramento della competitività nelle zone rurali mediante la diversificazione del tessuto produttivo.
Interventi, quest'ultimi, che travalicano la logica strettamente settoriale e mirano, mediante l'incentivazione di attività complementari ed alternative alla tradizionale offerta di prodotti agricoli quali:l'attività agrituristica, la ristrutturazione ed l'adeguamento di fabbricati rurali, la realizzazione di strutture sportive e ricettive, l'adeguamento e riadattamento di spazi aperti per le varie attività agrituristiche, ecc.), alla diversificazione economica del territorio, creando fonti alternative di reddito.
La normativa italiana in materia di agriturismo, nonostante la prima legge quadro è stata emanata nel 1985, risale agli inizi degli anni '50.
Difatti, con la legge 991 del 1952 ai coltivatori diretti è stata riconosciuta la possibilità di accedere a mutui per migliorie di carattere igienico e ricettivo da eseguirsi in strutture interne all'azienda agricola destinate ad ospitare i turisti.
Successivamente, la legge 352/76, in attuazione della Direttiva Comunitaria sull'agricoltura di montagna e sulle aree svantaggiate (Dir. 268/75), ha previsto (art.10) anche la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici per effettuare investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola.
Tale norma si è rivelata innovativa sia perche´ ha consentito, per l'esercizio dell'attività ricettiva, l'impiego di altre unità immobiliari interne all'azienda non adibite ad abitazione privata del proprietario, sia perche´ ha dato l'opportunità di praticare attività artigianali all'interno dell'unità produttiva.
Ciononostante, giuridicamente non veniva riconosciuta la polivalenza dell'attività agricola e si riteneva che l'attività turistica espletata in un'azienda agricola fosse “collaterale ed estranea all'attività agraria in senso stretto” e da considerarsi commerciale.
Soltanto dopo l'introduzione della Legge Quadro n. 730/1985 “Disciplina dell'Agriturismo”, che ha regolato fino a tutto il 2005 l'attività del settore, l'agriturismo ha ottenuto una sua collocazione nel panorama delle attività imprenditoriali.
Con tale normativa, si è evidenziata la necessità di monitorare il rapporto di complementarietà tra le due attività, al fine di garantire la predominanza dell'attività agricola su quella turistica, onde prevenire la dismissione della prima a favore della seconda.
Tali indicazioni sono scaturite nella successiva circolare ministeriale n° 10 del 27.06.1986 nella quale, per definire il rapporto di connessione tra le due attività e valutare l'integrazione del reddito agricolo con quello proveniente.
L'articolo 2 della legge 730/85 definisce giuridicamente l'attività agrituristica la quale “comprende, esclusivamente, le attività di ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori agricoli singoli o associati e dai loro famigliari attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere le attività principali dell'azienda.
Un'altra importante tappa normativa per il settore è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 che, all'art. 3 prevede, fra le altre attività agrituristiche, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratiche sportive, escursionistiche e d'ippoturismo, nonche´ la degustazione dei prodotti aziendali, ancorche´ svolte all'esterno dell'azienda.
Dal 2006, la legge quadro del 1985 in materia di agriturismo è stata sostituita dalla nuova legge quadro n. 96 del 20/02/2006.
Anche con questa nuova norma le regioni continuano ad avere un'ampia autonomia nel settore dell'agriturismo e sono chiamate, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, ad adeguare le leggi e i loro regolamenti di attuazione alle nuove norme nazionali.
I principali punti della nuova legge sono:
Il perno della nuova norma è una notevole semplificazione burocratica: le aziende più piccole, cioè quelle fino a dieci posti letto ed ad altrettanti “coperti” a tavola, sono dispensate da diversi obblighi, tra cui quello di dimostrare che l'attività agricola è preponderante rispetto a quella agrituristica.
La nuova legge quadro dispone che i piccoli agriturismi (sino a 10 posti)potranno utilizzare la cucina di casa per dare piatti caldi, e sarà sufficiente dimostrare la semplice abitabilità dei locali, senza dover per questo sottostare a complesse prescrizioni previste per le locazioni alberghiere o quelle simili (sanitarie, antincendio o di abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio). Per di più, anche le aziende più grandi beneficiano di una radicale semplificazione: ad esempio, per l'immediato avvio all'esercizio basterà una semplice “comunicazione di inizio attività” ed il Comune avrà tempo sessanta giorni per formulare motivati rilievi al piano aziendale. Peraltro, la sospensione dell'attività sarà possibile solo in caso di gravi carenze o irregolarità. E' un bel cambiamento, tenuto conto che ad oggi, in molte regioni, i permessi sono sottoposti a iter particolarmente faticosi e prevedono l'assenso esplicito al piano da parte delle autorità preposte.
L' agriturismo persegue obiettivi specifici aventi carattere:
La tabella 5 illustra la domanda e l' offerta di agriturismo per regione
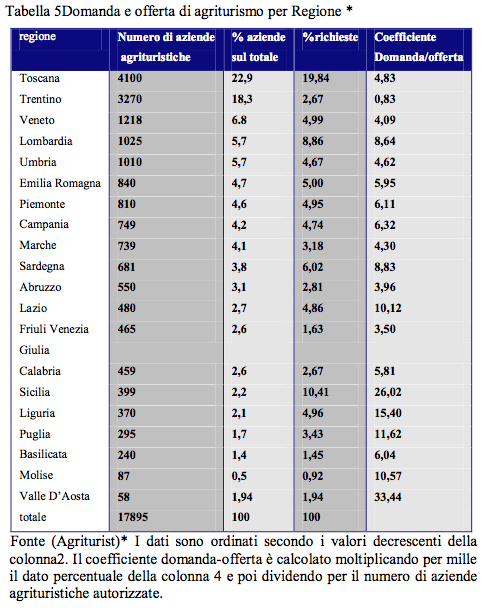
L' operatore agrituristico può svolgere attività di ricezione e di ospitalità utilizzando la propria azienda, offrendo:
camere arredate;
servizio uso cucina; somministrazione di uno o più pasti;
L' agriturismo italiano è una specifica e particolare offerta turistica nel verde, fatta da imprenditori agricoli, che non trova riscontri e modalità di comparazione nel resto d'Europa, infatti per l'Unione Europea il turismo verde o rurale comprende qualsiasi forma di attività turistica svolta in ambiente rurale, quali il turismo di campagna, nelle aziende agricole, l' agriturismo.
In Italia, invece, si distingue fra turismo rurale e agriturismo.
Il turismo rurale, disciplinato dalla legge quadro n 217 del 1983 indica attività turistiche che vengono praticate in zone rurali.
L'agriturismo, disciplinato dalla legge quadro n 730 del 1985 nel contesto dello sviluppo rurale sostenibile si colloca come strumento privilegiato rispetto ad ogni altro tipo di ricettività in campagna in quanto direttamente e strettamente collegato all'attività agricola essendo definito attività “complementare” ed “integrativa” rispetto a questa.
Le tabelle 6-7-8-9 riportano alcuni dati relativi ad un sondaggio Agriturist condotto mediante interviste rivolte ad un campione di 300 operatori di agriturismo sull'andamento del mercato agrituristico.

L'agriturismo è ritenuto un'attività in grado di:
La tabella 10 illustra le aziende agrituristiche autorizzate per regione.
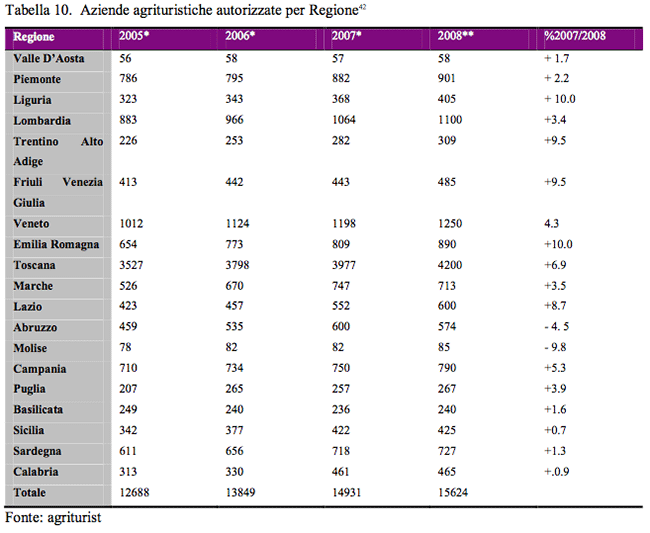
Le aziende agrituristiche possono avere differenti configurazioni ed anche nello stesso contesto geografico possono coesistere situazioni molto differenziate in quanto, l'azienda agrituristica è il frutto della combinazione di elementi umani, aziendali, normativi e ambientali estremamente vari.
Ciò nonostante possono essere individuati due grandi modelli di massima, ai quali è possibile ricondurre ogni attività turistica: le Aziende agrituristiche intensive e quelle estensive.
Le prime, sono quelle che prevedono un elevato impegno di manodopera per ospite e che per tale ragione non prevedono in genere un elevato numero di posti letto.
Si tratta di aziende di piccola media dimensione a conduzione diretta e dove l'offerta si presenta in modo assai variegato: vendita diretta dei prodotti tipici, organizzazione di attività culturali e ricreative.
Presso queste aziende il contatto con la clientela è molto stretto e la scelta della vacanza è motivata proprio dall' intereresse a vivere un soggiorno tipicamente rurale.
Le seconde, sono quelle aziende in cui si pratica un agriturismo “leggero”e dove l'impiego di manodopera ridotto all'essenziale.
I prodotti tipici e l'agriturismo sono strettamente legati infatti i primi caratterizzano i pasti dell'agriturismo e sono il valore aggiunto della produzione dell'azienda agrituristica. L'agriturismo è anche turismo enogastronomico: quattro ospiti su cinque desiderano consumare almeno un pasto della giornata preparato dall'agricoltore che li ospita con prodotti agricoli provenienti dall'azienda che li accoglie, e da altre aziende del territorio, ma anche e soprattutto con prodotti tipici del luogo, specialità alimentari locali espressione di "origine" ma anche di "tradizione" (ovvero di origine sia fisica, sia culturale).
Pertanto nell'agriturismo è forte il richiamo alla tradizione, e quindi la necessità di coniugare sempre, anche nell'offerta di assaggi e pasti, il gusto con la storia, i sapori con la cultura territoriale.
E' molto importante richiamare l'attenzione su questo aspetto, evidenziando una volta di più, per gli agriturismo, la funzione di vetrina dei prodotti tipici del territorio e quindi anche di promotori della riscoperta e della valorizzazione di questi prodotti. A cominciare da quelli che, come avviene quando si ottenga il riconoscimento DOP (denominazione d'origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta), non sono genericamente "prodotto tipico", ma rispondono a regole di produzione ben precise e sono quindi custodi ufficiali di tradizione e qualità.
I riconoscimenti della Denominazione d'Origine Protetta DOP e della Indicazione Geografica Protetta e IGP si prefiggono di tutelare e promuovere i prodotti agroalimentari legati alla tradizione e alle peculiarità di un determinato territorio. L'Italia, con la sua straordinaria ricchezza di prodotti tipici di specifiche aree geografiche, può trarre da tali riconoscimenti importanti vantaggi commerciali, sui mercati interni ed esteri. E il consumatore, ove correttamente informato, può scegliere il meglio del patrimonio agroalimentare del nostro Paese.
E' il caso di chiarire che si tratta di veri e propri marchi di qualità, rilasciati dall'Unione Europea su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di una istruttoria preliminare molto accurata e poi dell'impegno di tutti i produttori a sottoporsi al costante controllo di un ente terzo di certificazione.
I prodotti DOP e IGP si identificano per le caratteristiche peculiari legate alla applicazione puntuale di un disciplinare di produzione, e di cui sia comprovata l'origine "storica" nel territorio dichiarato nella denominazione.
La domanda di riconoscimento per i prodotti DOP e IGP, da inoltrare al Ministero delle politiche agricole e forestali, può essere presentata, di norma, esclusivamente da una organizzazione associativa (non è stabilita una precisa forma giuridica) che riunisca tutti gli operatori interessati. La domanda deve evidenziare tutti i fattori di identificazione del prodotto, la sua origine storica nel territorio citato nella denominazione, il disciplinare di produzione e l'ente terzo di certificazione (fra quelli riconosciuti dal Ministero) al quale è affidato il controllo sulla conformità della produzione al disciplinare.
Il Ministero acquisisce il parere della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competenti,verifica la rispondenza della domanda ai requisiti previsti dal Regolamento 510/2006 dell'Unione Europea, e poi, se non vi sono difformità con la norma, indice una riunione con l'Organizzazione dei produttori, la Regione (o Provincia autonoma) e la Camera di Commercio per una ulteriore verifica che il disciplinare di produzione risponda effettivamente ad usi leali e costanti così come previsto dal Regolamento della UE. Infine pubblica la proposta di disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attendendo 30 giorni per accogliere eventuali opposizioni. Terminata positivamente questa fase istruttoria, il Ministero trasmette la domanda alla Commissione dell'Unione Europea, che pure ne esamina la conformità al Regolamento 510/2006 e, in caso di esito favorevole, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale UE attendendo sei mesi per accogliere eventuali opposizioni. Trascorso tale periodo senza opposizioni, il prodotto ottiene il riconoscimento e viene perciò iscritto nell'apposito Albo comunitario.
Una volta che i prodotti hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP, la denominazione deve essere, presso i singoli produttori, costantemente soggetta a:
Il Consorzio di Tutela, organismo rappresentativo dei produttori, svolge anche le attività necessarie alla promozione e valorizzazione del prodotto DOP o del prodotto IGP sul mercato. Gli oneri dell'attività di certificazione sono a carico dei produttori che pertanto, in questo modo, investono per migliorare la propria professionalità e, soprattutto, per trasmettere ai consumatori una "sostanza" (non solo una "immagine") di serietà e passione per il proprio lavoro.
La differenza fra prodotti DOP e prodotti IGP sta nel fatto che, nel caso del prodotti DOP, tutto ciò che concerne l'elaborazione e la commercializzazione del prodotto, ha origine nel territorio dichiarato; mentre nel caso del prodotto IGP, il territorio dichiarato conferisce al prodotto, attraverso alcune fasi o componenti della elaborazione, le sue caratteristiche peculiari, ma non tutti i fattori che concorrono all'ottenimento del prodotto provengono dal territorio dichiarato.
Ovvero, la sigla DOP designa un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente dovute all'ambiente geografico ( termine che comprende fattori umani e naturali).
Ma l'aspetto più importante da rilevare è che tutta la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto devono avvenire nell'aria delimitata.
La sigla IGP introduce un nuovo livello di tutela qualitativa che tiene conto dello sviluppo industriale del settore, dando più peso alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale.
Quindi la sigla identifica un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità, reputazione e caratteristiche si possono ricondurre all'origine geografica, e di cui almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nell'aria delimitata.
Inoltre per STG ( specialità tradizionali garantite) si intendono l' insieme di elementi, che per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono un prodotto da altri simili.
Ci si riferisce quindi a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità.
Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le STG dai DOP e IGP.
In sintesi vengono riportati i simboli che si riferiscono alle certificazioni di qualità.
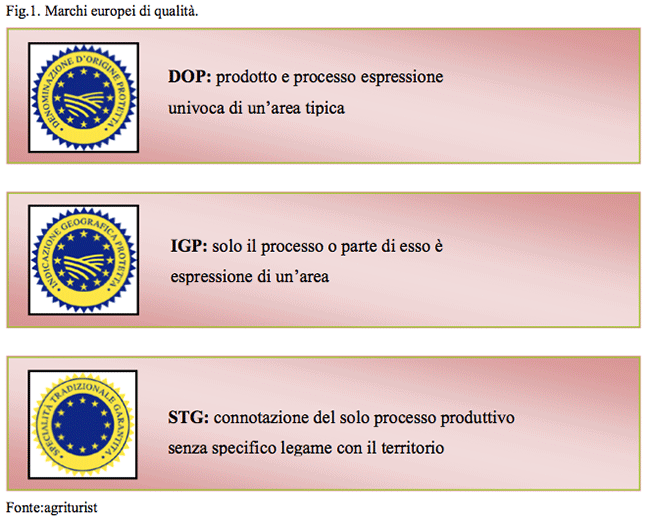
I paesi europei che hanno il maggior numero di prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP sono l'Italia e la Francia.
I prodotti italiani riconosciuti attualmente sono complessivamente 182, 117 a denominazione d'origine protetta, 65 ad indicazione geografica protetta. Guardando alle categorie merceologiche, sono al primo posto gli ortofrutticoli, con 56 riconoscimenti, dei quali 13 DOP e 43 IGP; segue l'olio extravergine d'oliva con 37 DOP e una IGP; poi i formaggi e i caseari, con 35 DOP, le carni (salumi e carni fresche) con 20 DOP e 13 IGP.
Guardando alla distribuzione regionale, abbiamo, al nord, 27 riconoscimenti per l'Emilia Romagna e il Veneto, 21 per la Lombardia. Nell'Italia Centrale spicca la Toscana con 19, al sud Sicilia con 17.
I riconoscimenti non riguardano soltanto prodotti freschi o tradizionali trasformazioni agricole. Abbiamo infatti anche cinque tipi di pane (Coppia Ferrarese IGP, Casareccio di Genzano IGP, Pane di Altamura DOP, Pane di Matera IGP, Pagnotta del Dittaino DOP), due tipi di prodotto ittico (Acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP e Tinca Gobba Dorata dell'Altopiano del Poirino DOP), un'essenza non alimentare (Bergamotto di Reggio Calabria DOP) e una preziosa spezia, lo zafferano (Zafferano di S. Gimignano DOP, Zafferano dell'Aquila DOP, Zafferano di Sardegna DOP).
Le tabelle 11-12 mostrano i prodotti DOP e IGP riconosciuti per settore e per regione in Italia.