L'attività turistica è in grado di contribuire significativamente alla crescita economica del territorio, in particolare di quello rurale.
Il turismo si avvale infatti di una ”materia prima” del tutto particolare, quale appunto il territorio inteso come l' insieme dei segni che la natura e la storia hanno inciso sui suoi confini.
Il fenomeno “turismo” include comparti produttivi estremamente diversi fra loro:
Al turismo viene attribuita una natura ambivalente in quanto esso può contribuire positivamente allo sviluppo socio-economico e culturale della destinazione ma può allo stesso tempo, se sviluppato in maniera incontrollata, causare fenomeni di degrado ambientale della cultura e delle tradizioni locali. Per cui è necessaria una costante verifica di coerenza trai benefici che derivano dalla “pratica turistica” e i costi da valutare in termini di sostenibilità ambientale, preservazione dell' individualità e delle peculiarità dei beni naturali ed artistici.
Ed è proprio in tale ottica che si è sempre piu` affermato il concetto di turismo sostenibile inteso come: “modello di offerta turistica attenta alla tutela delle risorse naturali, alla promozione di effettivi benefici economici per le popolazioni locali e al rispetto delle peculiarità socio-culturali della destinazione.”
Il progressivo affermarsi di attività turistiche esercitate in stretta connessione con l'ambiente naturale ha suscitato, soprattutto negli ultimi anni un grande interesse in relazione alla tutela e alla salvaguardia ambientale favorendo lo sviluppo di attività turistiche a basso impatto ambientale quali il turismo rurale e l'agriturismo.
Il turismo rurale viene individuato come un particolare prodotto del mercato turistico locale, in cui confluiscono molteplici attività: (ricettive, ricreative, sportive di ristorazione e di tempo libero), svolte in forma sinergica e coerente con la corretta fruizione dei beni naturali e culturali e compatibilmente con le risorse ambientali, naturalistiche e culturali del territorio rurale, inteso come spazio non urbanizzato, attraverso il recupero e l'utilizzazione del patrimonio edilizio rurale esistente.
Gli elementi che lo caratterizzano possono essere individuati in relazione al fatto che:
Il turismo rurale, in definitiva è caratterizzato da un' insieme di esperienze quali l'inserimento nel milieu rurale e il contatto diretto con lo stesso, fino alla partecipazione in attività legate alla produzione agricola e alla trasformazione dei prodotti dell'agricoltura.
Il turismo rurale include nello specifico lo svolgimento di tutte quelle attività praticabili in ambiti e luoghi ben definiti:
L'agriturismo rappresenta un' attività turistica connessa all'impresa agricola e permette ai turisti di conoscere il contesto rurale, l'agricoltura e le sue produzioni attraverso l' accoglienza e l'ospitalità presso l'azienda agricola.
L'offerta agrituristica racchiude diversi servizi tra cui il pernottamento, la ristorazione, la vendita diretta dei prodotti della fattoria, l'attività didattica rivolta alle scolaresche. Nell'insieme delle attività turistiche, in cui assume un forte valore il territorio, rientra l' ecoturismo che racchiude tutte le forme di turismo concentrate sulla natura e nelle quali la motivazione principale del turista risulta essere quella di osservare la natura e la cultura tradizionale, da cui scaturiscono effetti positivi in relazione alla protezione dell'ambiente procurando vantaggi economici alla popolazione locale, alle organizzazioni impegnate nella salvaguardia ambientale, promuovendo la tutela del capitale naturale.
Nelle forme di turismo legate al valore della natura assume importanza la presenza nel territorio di prodotti agroalimentari dotati di caratteristiche particolari di riconoscibilità. n prodotto si può considerare tipico, quando in esso si realizza la concomitanza di alcuni fattori, che sono riconducibili alla sua memoria storica, alla localizzazione geografica delle aree di produzione, alla qualità delle materie prime impiegate nella loro produzione, ed alle relative tecniche di preparazione.
Il prodotto tipico va inteso non solo come prodotto alimentare, ma anche come il prodotto di un territorio, delle sue risorse naturali e culturali.
La materia prima è considerata di qualità in quanto prodotto di un territorio circoscritto e le tecniche di preparazione rappresentano l' esperienza degli artigiani e i mezzi e le metodologie tramandate.
E` il frutto del lavoro creativo e dell'impegno operativo di intere generazioni; il risultato di elaborazioni progressive; è qualcosa che ha una storia da raccontare. Una storia che non si limita nel tramandare le modalità di produzione, le materie prime adoperate ma richiama per intero il contesto socio-culturale.
In questo senso, il prodotto tipico si può definire come “territoriale” in quanto detentore di numerosi aspetti della vita sociale di un territorio.
Ne consegue che i prodotti non tipici possono eguagliare i prodotti tipici nel raggiungimento degli standard qualitativi, ma non potranno mai detenere il requisito della territorialità e non porteranno mai con se´ l'eco di una storia, di un territorio, di una cultura. Il prodotto tipici diviene quindi espressione della cultura di un popolo.
E` noto come il concetto di tipicità sia notevolmente diffuso fra i consumatori, tuttavia a tale concetto non va attribuita un'unica chiave interpretativa.
La confusione circa il concetto di “tipicità” deriva dal fatto che ad esso vengono spesso associati significati diversi, quali ad esempio:
Di frequente il consumatore è indotto a percepire come prodotti tipici prodotti di natura industriale non aventi alcun vincolo/relazione con il territorio, mediante politiche di promozione mirate.
La tipicità ha assunto particolare rilievo nel corso soprattutto degli ultimi anni in considerazione degli allarmi sulla sicurezza alimentare che ha richiesto l'attivazione della tracciabilità e della rintracciabilità dei processi.
La prima fonte di tutela giuridica di cui hanno beneficiato i prodotti agro-alimentari di qualità è rappresentata dall'uso dei marchi collettivi nati dall'aggregazione dei produttori.
Il marchio collettivo nasce nel 1911 a Washington a seguito della revisione della Conferenza di Parigi del 1883 sui diritti di proprietà industriale.
Esso si differenzia dal marchio industriale, il quale, identifica il prodotto fabbricato o messo in commercio dal suo titolare al quale viene riservato per legge l'utilizzo del marchio medesimo.
La funzione del titolare del marchio è quella di garantire una definita caratteristica del prodotto (qualità, natura, origine) ai consumatori finali.
Il successo del marchio non dipenderà quindi solo dalla qualità del bene del singolo produttore ma dalla capacità di quest'ultimo di conquistare la fiducia dei consumatori.
Il marchio collettivo avrà successo, se il titolare sarà in grado di garantire la qualità di quei beni da esso contraddistinti conquistando la fiducia del consumatore che sarà indotto ad acquistare il bene pur non conoscendo l' identità del singolo produttore.
Ma perche´ risulta rilevante porre l'attenzione al concetto di marchio?
Perche´ inizialmente le DOP e le IGP erano semplici marchi collettivi tutelati mediante norme nazionali e solo successivamente la necessità di estendere il valore del marchio ha portato al riconoscimento giuridico al di fuori dell'originario Stato di registrazione. La prima Convenzione Internazionale concernente la tutela di prodotti agro-alimentari da sottoporre a tutela si è svolta a Lisbona nel 1958 e a risulta vigente nella versione adottata a Stoccolma nel 1967.
Essa consente ad ogni Stato aderente alla Convenzione di far valere le regole in essa contenute al fine di tutelare i propri prodotti di origine all' interno degli altri Stati che fanno parte della stessa convenzione.
La tutela alla quale si riferisce la Convenzione riguarda unicamente quella accordata dalla normativa dello Stato di provenienza del prodotto.
Rilevante è la Convenzione di Stresa del 1951 riguardante i formaggi, ratificata in Italia con il DPR del 18/11/1953 n 1099, così come l' accordo TRIPS approvato a Marrakech nel 1994, riguardante la proprietà industriale e le DOP introdotto in Italia con il decreto legislativo del 19/03/1996 n 198.
Nonostante queste convenzioni abbiano permesso di rafforzare la tutela delle indicazioni nei vari Stati membri le contestazioni circa le protezioni giuridiche delle stesse hanno continuato a manifestarsi, da qui è stata avvertita l' esigenza dell'introduzione di una normativa uniforme al fine di assicurare una tutela omogenea delle DOP e IGP.
Tali chiarimenti saranno rilevanti nella trattazione del turismo enogastronomico dove ci soffermeremo nello specifico sulla trattazione dei. marchi di qualità e ci permettono inoltre di comprendere come il processo di riconoscimento di un prodotto non sia così semplice e come sia stata già negli anni trascorsi avvertita l' esigenza di una tutela giuridica di tali prodotti.
Abbiamo spesso menzionato il concetto di qualità; ma cosa si intende per qualità di un prodotto?
Il concetto di qualità necessita di una definizione, generalmente viene associato ai prodotti, ma in realtà la qualità può riguardare i processi e i flussi produttivi.
La norma ISO 8402 definisce il termine qualità come “l'insieme delle caratteristiche e dei valori di un'entità che ne determinano la capacità di soddisfare esigenze espresse ed implicite del consumatore”.
Al concetto di qualità intesa nel suo complesso bisogna aggiungere:
Ma quali sono i metri di giudizio del consumatore circa un prodotto di qualità? Il consumatore giudica la qualità di un prodotto soprattutto in base:
La tabella 1 mette in evidenza i fattori che determinano la qualità di un prodotto alimentare per i consumatori.( su un campione di 1046 casi)
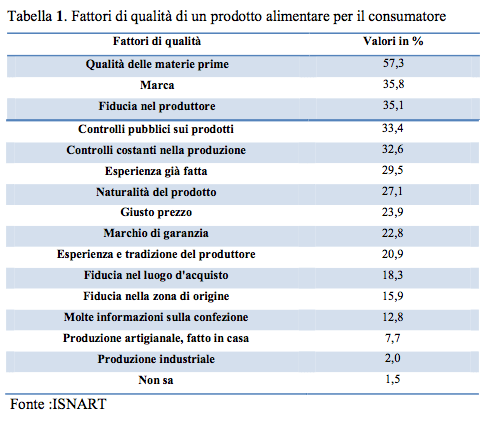
Il concetto di tipicità è elemento necessario e imprescindibile di correlazione tra ambiente e territorio.
Tale correlazione tra ambiente e territorio può riguardare:
Esistono diversi gradi di specificità:
La tipicità di un prodotto può essere:
La Coldiretti stima nel 2005 per i soli DOP e IGP:
La tabella 2 mostra il contributo dei prodotti:
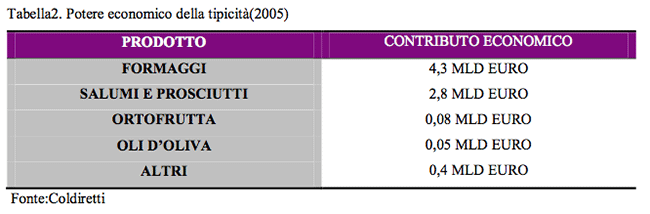
A questi valori si devo inoltre aggiungere quelli dei vini e l‘Italia secondo Coldiretti è il secondo paese produttore di vino in Europa con un fatturato pari a 8 mld di euro e un valore d'esportazione di 2,5 mld.
Possiamo concludere dicendo che la tipicità esprime una componente rilevante della differenziazione dei prodotti agroalimentari fondata su un legame o un vincolo inscindibile tra prodotto e il territorio.
Le produzioni tipiche stanno diventando sempre piu` un elemento di differenziazione e di qualificazione di interi territori, diventandone una delle risorse o, in taluni casi, la principale risorsa e il vero fattore di attrattiva turisticamente rilevante delle località turistiche che rivolgono le proprie strategie di promozione del territorio ai nuovi segmenti di domanda turistica (i turisti del gusto o gastronauti, i turisti verdi). In questo senso diventa fondamentale attivare sinergie e relazioni commerciali con il sistema economico locale (per esempio con la ristorazione, il commercio, l'artigianato) in modo da consolidare l'antico legame territoriale in maniera attiva, rafforzandone l'immagine presso i consumatori: fungendo così effettivamente da strumento di promozione e godendo dei benefici derivati da tali approcci.
I prodotti tipici locali richiedono un impegno di valorizzazione e informazione superiore agli altri prodotti, data la limitata produzione e diffusione che li rendono sconosciuti presso il grande pubblico.
Ma cosa si intende per valorizzazione di un prodotto?
Limitandosi ad una analisi puramente commerciale si tratta di attribuirgli il giusto valore e di far si che tale valore sia riconosciuto sul mercato.
Tuttavia gli ostacoli e le problematiche che si possono presentare possono essere di diversa natura, e possono riguardare:
A fronte di questi problemi emergono segnali positivi, che spingono a guardare con fiducia il futuro commerciale dei prodotti locali:
La possibilità del settore primario di svilupparsi attraverso le produzioni agro-alimentari tipiche dipende anche dalla capacità di tale offerta di incontrare determinati segmenti di domanda.
Se così non fosse ciò significherebbe relegare i percorsi di tipicizzazione ad una grande esposizione di opere d'arte che non avrebbero però estimatori e visitatori.
Dai risultati di un' indagine condotta da Coldiretti nel 2007 emerge che la tipicità di un prodotto alimentare viene individuata dal 32% dei consumatori nella definizione “prodotto genuino senza conservanti”dal 24,5% in “ prodotto fatto con materie prime del territorio”,dal 18,5% in “prodotto fatto con metodi artigianali”, dal 16%” prodotto realizzato con ricette tradizionali” e dal 9,5%” prodotto acquistabile direttamente nel luogo di produzione”.
Se in termini generici appare evidente un' interesse sull'attributo della tipicità, dalla verifica relativa alla conoscenza dei marchi di tutela e delle certificazioni di qualità sono sconosciute dalla maggioranza dei consumatori, come emerge dalla tabella 3.
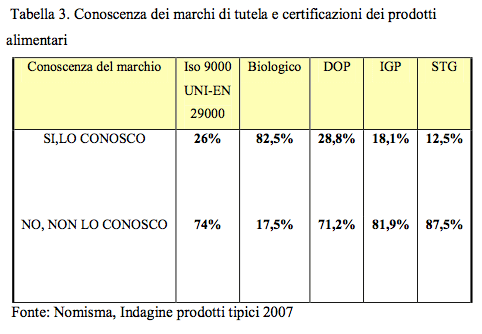
Oltre 80% degli intervistati non conosce il significato di IGP e STG; il 72% quello di DOP e il 74% non conosce le dizioni ISO 9000 e Uni- En 29000. Solo nel caso di produzioni biologiche si verifica un' ampia conoscenza del marchio.
Nonostante la scarsa conoscenza degli strumenti comunitari e delle garanzie in materia, il consumatore manifesta interesse verso i prodotti tipici,come testimonia la disponibilità a pagare un prezzo piu` elevato per gli stessi.
Appare fondamentale promuovere al meglio l'immagine di questi prodotti, puntando sulla storia del prodotto e la personalizzazione di chi lo produce.
Occorre infatti tener conto del fatto che molti prodotti tipici non sono noti al consumatore che pertanto non ne conosce l' esistenza.
Egli deve quindi, essere informato sull'origine, le tecniche di produzione, la cultura di cui il prodotto è manifestazione e segno. Chi acquista cerca forme di tutela e di garanzia che possono essere individuati dal Marchio, e che per quanto concerne i prodotti tipici sono rappresentati dai marchi di qualità istituiti dall'Unione Europea. L'attivazione di un processo di valorizzazione di un prodotto richiede innanzitutto l' esaltazione delle sue caratteristiche favorevoli, cercando di controllare quelle sfavorevoli.
Fra le caratteristiche favorevoli dei prodotti tipici vi è indubbiamente la qualità, un prodotto ottenuto mediante tecniche artigianali, fa venire in mente mani esperte che con passione e tradizione compiono gesti precisi e lenti, gesti che sanno di racconti tramandati, di tecniche pazientemente apprese, gesti che nessuna macchina potrebbe sostituire, perche´ rispondono a quella caratteristica di unicità che si contrappone drasticamente alla caratteristica di serialità dei prodotti industriali.
L'idea di qualità che scaturisce, non è soltanto l'idea romantica radicata nell'immaginario collettivo, è la realtà oggettiva dei prodotti tipici.
Le imprese produttrici hanno spesso dimensioni modeste, scarso potere di mercato non potendo così sfruttare strategie e tecniche di promozione.
Per rendere veramente efficace un prodotto che ha ottenuto una denominazione di origine Geografica, o di tipicità, è necessario utilizzare strategie collettive di produzione e di mercato.
D'altro canto però, i prodotti tipici si adattano bene alle forme di concorrenza non basate sul prezzo ma sulla qualità, prestandosi alla vendita al consumo presso i negozi di specialità alimentari ed ai settori specializzati della grande distribuzione. Occorre attuare una strategia di tutela e valorizzazione che trovi l' elemento fondamentale nell'esaltazione del rapporto tra prodotto e specificità locale.
Anche in quest' ultimo contributo ritornano termini come “usi, tradizioni, cultura”, termini che sottintendono tutti ad un concetto comune, quello di tipicità.
